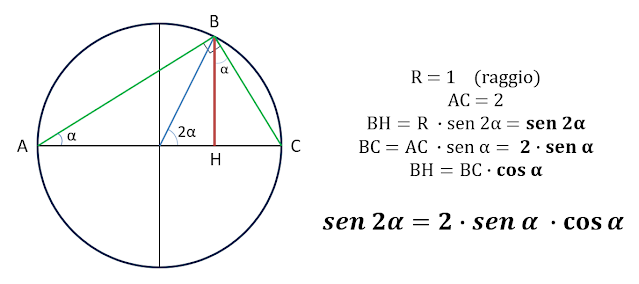Considerate una focaccina rotonda al
prosciutto: una fetta di pane, una di prosciutto e un’altra fetta di pane. Per
dividere a metà le 3 fette con un coltello, basta che il taglio passi per il
centro delle circonferenze. E se le 3 fette non fossero correttamente impilate?
O peggio, se aveste urtato il panino e una fetta di pane fosse rimasta sul
tavolo, il prosciutto sulla sedia e l’altra fetta sul pavimento?
Anche in questo caso la geometria ci assicura
che un singolo taglio (cioè, un singolo piano), potrà ancora dividere
perfettamente in due tutti e tre i pezzi, lasciando esattamente metà del
prosciutto e metà di ciascuna fetta di pane su entrambi i lati del taglio.
Questo perché il “teorema del panino al prosciutto” asserisce che per tre oggetti
qualsiasi (potenzialmente asimmetrici) in qualsiasi orientamento, c’è sempre un
piano che può dividerli tutti simultaneamente in due parti uguali.
In due dimensioni, si possono disegnare due
forme qualsiasi e ci sarà sempre una linea retta (unidimensionale) che taglia
entrambe perfettamente a metà.
Per garantire un taglio uguale per tre
oggetti, dobbiamo passare alle tre dimensioni e tagliare con un piano
bidimensionale.
In uno spazio quadridimensionale,
un panino al prosciutto con quattro ingredienti può essere diviso in due con un
taglio tridimensionale.
Per avere un'idea di
come dimostrare il teorema del sandwich al prosciutto, si consideri una
versione semplificata: due forme 2D, una un cerchio e l'altra con forma
qualsiasi. Una linea che passi attraverso il centro di un cerchio lo dividerà
in due (utilizziamo un cerchio per rendere le cose più facili). Scegliamo ora
una linea attraverso il centro del cerchio che non intersechi l’altra figura. Il
100% della figura si trova, ad esempio, sotto la nostra linea. Ora ruotando
lentamente la linea attorno al centro del cerchio, questa ne taglierà una
percentuale sempre minore e, alla fine, arriverà allo 0%. Da questo possiamo
dedurre che deve esserci un momento in cui il 50% della massa si trova sotto la
linea. Stiamo passando gradualmente ma continuamente dal 100% allo 0%, il che
significa che a un certo punto saremo esattamente al 50%.

The Strangely Serious Implications of Math's 'Ham Sandwich Theorem' | Scientific American
In questo caso esiste
una linea che divide in due simultaneamente le nostre forme (sebbene non ci
dica dove si trova quella linea). Si basa sul fatto che ogni linea che passa
per il centro di un cerchio lo divide in due; quindi, possiamo ruotare
liberamente la nostra linea e concentrarci sulla figura senza preoccuparci di
trascurare il cerchio. Due forme asimmetriche richiedono una versione più
sottile della nostra tecnica, e l’estensione alle tre dimensioni implica
argomenti più sofisticati.
Il teorema del panino
al prosciutto, noto anche come teorema di Stone-Tukey, afferma che dati n oggetti in uno
spazio n-dimensionale, di forme, dimensioni e posizioni qualsiasi,
esiste sempre un iperpiano (n-1)-dimensionale in grado di bisecarli
tutti simultaneamente. Esempi pratici del teorema:
- Fisica: tre nuvole di gas nello spazio, il
teorema assicura che esiste sempre un piano che divide esattamente metà della
massa di ciascuna nuvola su ciascun lato del piano.
- Statistica: tre distribuzioni di dati in uno
spazio tridimensionale, il teorema garantisce che esiste un piano che divide
equamente i dati di ciascuna distribuzione.
Si tratta di un
importante risultato topologico noto anche come corollario al teorema di Borsuk-Ulam:
per ogni funzione
continua che mappa la superficie di una sfera in uno spazio Euclideo, esistono
due punti diametralmente opposti sulla sfera che vengono mappati nello stesso
punto.
Un esempio classico si
ha in dimensione 2 (sulla superficie di una sfera); supponiamo che la funzione
rappresenti temperatura e pressione atmosferica in ogni punto
della Terra. Il teorema di
Borsuk-Ulam implica che esiste sempre una coppia di punti diametralmente
opposti sulla superficie terrestre che hanno esattamente stessa temperatura
e pressione.
Il teorema di Borsuk-Ulam
è strettamente connesso con il teorema del punto fisso di Brouwer.
Entrambi appartengono al campo della topologia e condividono alcune idee
fondamentali legate alla simmetria e alla continuità.
Un classico esempio
del teorema del punto fisso di Brouwer (caso bidimensionale come un disco): data
una funzione continua che "deforma" il disco senza sollevarlo dai
suoi bordi, ci sarà sempre almeno un punto che rimane fisso.
I due teoremi sono
collegati perché entrambi riflettono il comportamento di mappe continue e sono
radicati in concetti di simmetria e compattezza.
Entrambi i teoremi
hanno importanti applicazioni comuni nella matematica e nell'economia, dove
concetti come l'esistenza di punti fissi (Brouwer) o l'equilibrio tra elementi
(Borsuk-Ulam) sono utilizzati per risolvere problemi di ottimizzazione o di
equità e sono esempi di come le proprietà topologiche degli spazi continui
impongano restrizioni sulle mappe, garantendo l'esistenza di punti con
proprietà particolari, come punti fissi o coppie di punti antipodali che si
comportano allo stesso modo.
Il teorema di Brouwer
ha risvolti semplici ma sorprendenti:
- mescolando una tazzina di caffè, in ogni
momento almeno un punto del caffè si trova nel punto iniziale (anche se non
possiamo sapere quale con esattezza),
- se si mette per terra una cartina stradale del
posto in cui ci si trova (con qualsiasi scala), almeno un punto della cartina
coinciderà con il luogo che rappresenta.
Zibaldone Scientifico: 31. Teorema
del punto fisso di Brouwer (zibalsc.blogspot.com)
Utilizzando una
versione intuitiva del teorema di Borsuk-Ulam si può dimostrare che, per un
escursionista che in un fine settimana sale ad un rifugio il sabato e torna per
lo stesso sentiero la domenica partendo alla stessa ora, c'è sempre un punto in
cui l’escursionista si troverà nello stesso posto alla stessa ora in entrambi i
giorni.
Quindi la domanda è:
esiste un momento in cui, in entrambi i viaggi, lo scalatore si trova
esattamente nello stesso punto del sentiero alla stessa ora?
La risposta è sì. Possiamo
immaginare di confrontare il percorso di salita e il percorso di discesa come
due funzioni continue che descrivono la posizione dello scalatore lungo il
sentiero in base al tempo.
La funzione, che
misura la distanza tra la posizione dello scalatore durante la salita e quella
durante la discesa in un dato momento della giornata, è continua e all'inizio
della giornata (al momento della partenza) la distanza tra le posizioni è
massima (uno sta al piede della montagna e l'altro alla cima). Alla fine della
giornata (all'ora di arrivo), la distanza è ancora massima, ma opposta (uno è
in cima e l'altro è al piede).
Essendo questa una
funzione continua, per il teorema degli zeri si conclude che deve
esistere almeno un momento della giornata in cui la distanza è zero. Cioè, in
un certo istante, lo scalatore si trova nello stesso punto del percorso sia
durante la salita che durante la discesa.
Quindi, indipendentemente
dalla velocità con cui lo scalatore sale o scende, ci sarà sempre un punto
lungo il sentiero in cui egli si troverà alla stessa ora sia durante il primo
giorno (salita) che il secondo giorno (discesa).
Ancora più semplice,
se due persone partono contemporaneamente dai due estremi, da qualche parte si
incontreranno sicuramente.
TESI TRIENNALE
GIACOMO SARAGONI.pdf (unibo.it)
Teorema del panino al
prosciutto - Wikipedia
Category:Fixed
points (mathematics) - Wikipedia
Ham Sandwich
Theorem -- from Wolfram MathWorld
Sandwich
problem / Etudes // Mathematical Etudes
Zibaldone
Scientifico: 31. Teorema
del punto fisso di Brouwer (zibalsc.blogspot.com)
Domanda:
Che cosa è meglio, l’eterna felicità o un panino al prosciutto?
Sembrerebbe che fosse meglio l’eterna felicità, ma in realtà
non è così!
Dopo tutto, niente è meglio dell’eterna felicità e un panino
al prosciutto è certamente meglio di niente.
Quindi un panino al prosciutto è meglio dell’eterna felicità.
Tratto da Raymond
M. Smullyan - Qual è il titolo di questo libro? –
Zanichelli