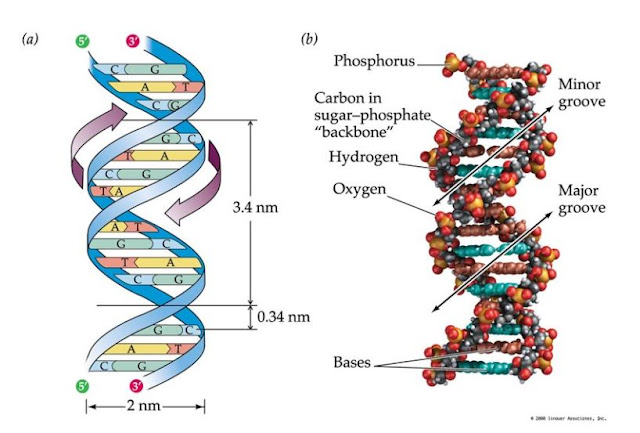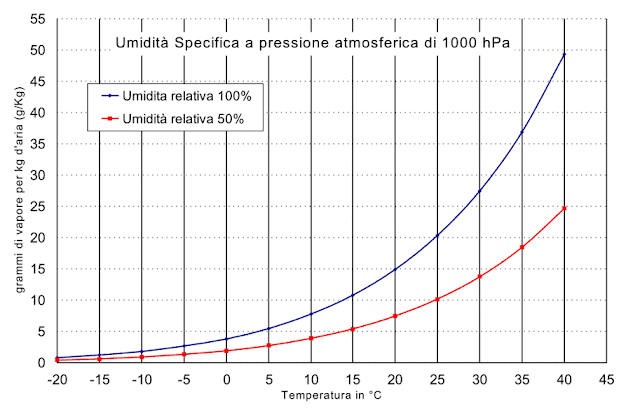“Fare ricerca significa
essere ignoranti per gran parte del tempo e fare spesso errori.”
Yves Meyer
Questo simpatico signore è Yves Meyer, professore emerito all’Ėcole Normale Supérieure
Paris-Saclay. In passato è stato insignito del premio Salem (1970) e del premio
Gauss (2010); quest’anno l’Accademia norvegese di Scienze e Lettere ha deciso
di attribuirgli il Premio Abel per
il 2017. Se volete saperne di più, potete leggere qui: http://www.abelprize.no/binfil/download.php?tid=69563
L’interesse di Meyer per quelle che potrebbero essere
chiamate le strutture e le regolarità di oggetti matematici complessi lo indusse
negli anni Sessanta a elaborare una teoria sui “set di modelli”, ovvero un modo per descrivere sequenze di oggetti
che non hanno la regolarità perfetta e la simmetria del reticolo cristallino.
Questo lavoro, che prese le mosse dalla teoria dei numeri, fornì la base
teorica per i materiali chiamati quasi-cristalli,
individuati per la prima volta nel 1982 nelle leghe metalliche, ma prefigurati
già nel 1974 dalle tassellature
semiregolari identificate dal fisico-matematico Roger Penrose. La scoperta dei quasi cristalli valse nel 2011 a Dan Schechtman, professore di scienze
dei materiali, il premio Nobel per la chimica. Meyer continuò a coltivare il
suo interesse per i quasi-cristalli, e nel 2010, insieme a Basarab Matei, contribuì a spiegare la loro struttura matematica.
 |
| Ho-Mg-Zn Quasi-cristallo |
Potrei proseguire parlando di questi argomenti, ma
preferisco concentrarmi sui numeri di Pisot-Vijayaraghavan
che possono essere usati per generare quasi-interi
e studiare i quasi-cristalli: avendo
la proprietà che la potenza n-esima di un numero di Pisot
"si avvicina a un intero"
al tendere di n ad infinito.
In particolare il numero aureo Φ (phi) possiede questa
proprietà e non è difficile dimostrarlo
partendo dalla definizione del numero aureo stesso, ottenuto come prima soluzione
dell’equazione: X2 - X - 1 =
0 , X1
= 1,6180339887..
La seconda soluzione è invece X2 = - 0,6180339887.., da cui, per la proprietà delle soluzioni di un’equazione di secondo grado, si ottiene X1 X2 = - 1 e X1 + X2 = 1 con semplici passaggi algebrici si vede che il generico prodotto (X1)n (X2)n = (-1)n mentre la generica somma (X1)n + (X2)n non è altro che la Sequenza di Lucas (2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, …) che ha una stretta relazione con la Serie di Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …). Dal fatto che il secondo termine tende a zero, si ha che il numero aureo è un quasi-intero al crescere di n. Nel seguente grafico viene riportata la differenza tra la potenza n-esima del numero aureo e l’intero più vicino:
La seconda soluzione è invece X2 = - 0,6180339887.., da cui, per la proprietà delle soluzioni di un’equazione di secondo grado, si ottiene X1 X2 = - 1 e X1 + X2 = 1 con semplici passaggi algebrici si vede che il generico prodotto (X1)n (X2)n = (-1)n mentre la generica somma (X1)n + (X2)n non è altro che la Sequenza di Lucas (2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, …) che ha una stretta relazione con la Serie di Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …). Dal fatto che il secondo termine tende a zero, si ha che il numero aureo è un quasi-intero al crescere di n. Nel seguente grafico viene riportata la differenza tra la potenza n-esima del numero aureo e l’intero più vicino:
E non è finita qui. Se mettete i valori assoluti di questi valori in un grafico con ordinate in scala logaritmica:
Per
chiarimenti potete consultare il sito di Mauro Fiorentini:
La radice quadrata di 5 appare, quasi ovviamente, nei
pentagoni e come visto nel numero aureo, ma la cosa matemagica è che le 2 sequenze,
che sono messe in relazione dalla radice quadrata di 5 (quindi irrazionale)
possano essere entrambe quasi intere
e entrambe in stile Fibonacci.
Questo
è il primo post della “Trilogia dei Penrose”, nel prossimo
si parlerà di dardi ed aquiloni e poi probabilmente di vite parallele.
http://anthelion.blog22.fc2.com/blog-category-2.html
http://zibalsc.blogspot.it/2016/02/203-fattoriale-fibonacci-e-conigli.html
http://zibalsc.blogspot.it/2011/12/90-ottantanove-bis.html
http://zibalsc.blogspot.it/2016/02/203-fattoriale-fibonacci-e-conigli.html
http://zibalsc.blogspot.it/2011/12/90-ottantanove-bis.html