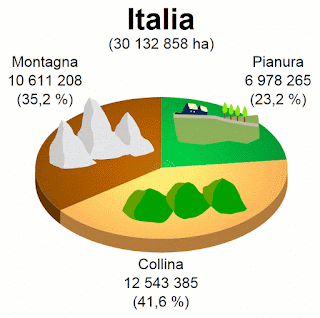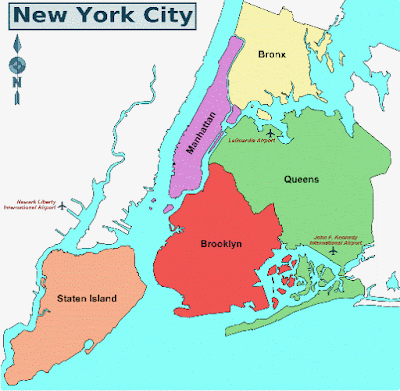Ogni volta che, dopo una forte pioggia,
si hanno allagamenti e esondazioni, i telegiornali forniscono informazioni di
questo tipo:
“negli
ultimi anni il consumo di suolo in Italia è cresciuto a una media di 8 metri
quadrati al secondo.”
La serie storica dimostra che si tratta
di un processo che dagli anni cinquanta non conosce battute d’arresto; negli
anni novanta la crescita era addirittura di 10
metri quadrati al secondo. La percentuale di suolo utilizzato è passata dal
2,7% del 1956 al 6,8% del 2010, con un incremento di 4 punti
percentuali. In altre parole, sono stati consumati, in media, più di 7 metri
quadrati al secondo per oltre 50 anni.
In termini assoluti, l’Italia è passata
da poco più di 8.000 km2
di consumo di suolo del 1956 a oltre
20.500 km2 nel 2010.
Un aumento che non si può spiegare solo
con la crescita demografica: se nel 1956
erano consumati 170 m2 per
ogni italiano, nel 2010 il
valore è raddoppiato, passando a più di
340 m2.
L’Italia ha una superficie di 301.328 km2. Il 23,2% è pianura, il 35,2% è collina e il 41,6% montagna.
Per cui la superficie “consumabile” si riduce a poco più del 50%.
Un consumo di 8 metri quadrati al
secondo corrisponde a 2 campi da tennis al minuto o 252 km2
all’anno. Questo significa che ogni 5 mesi viene cementificata una superficie
pari a quella del comune di Napoli e ogni anno una pari alla somma di quella di
Milano e Firenze.
Wikipedia alla voce “Coste italiane” riporta:
“lo sviluppo costiero della penisola
italiana e delle sue isole si aggira sui 7.458 km.”Le isole contribuiscono con una buona percentuale.
Questo valore è almeno il 50% maggiore della distanza
che si deve percorrere per andare da New York a Los Angeles o da Mosca a
Lisbona, ma se paragonato a strade ed autostrade si possono fare interessanti
considerazioni.
Lo sviluppo costiero è all’incirca
uguale alla lunghezza della rete autostradale. Mentre è poco più di un
centesimo della totalità delle strade.
Il Comune di Roma è molto esteso (quanto nove grandi città). Infatti, con i suoi 1.286
km2 amministra un territorio grande come quello di Milano, Torino,
Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania e Palermo messi insieme.
L’insieme delle sue strade ha una lunghezza di circa 5.500 chilometri. Decisamente
senza confronto rispetto ad altre città italiane (Bari 550 Km, Bologna 770 Km,
Catania 600 Km, Firenze 750 Km, Genova 1.400 Km, Milano 1.500 Km, Napoli 1.090
Km, Torino 1.300 Km).
Il fatto che la totalità delle strade di
Roma sia dello stesso ordine di grandezza dello sviluppo costiero italiano ha
dell’incredibile e può in parte aiutare a capire come sia difficile prendersi cura del
servizio della loro manutenzione.
Per
concludere, vorrei citare un esempio abbastanza familiare.
L’isola di Manhattan (87 km2) è una piccola parte dell’intera New York (784 km2).
Le strade sono disposte a matrice: le
Street orizzontali e le Avenue verticali.
Due Street e due Avenue definiscono un
isolato (blocco).
In Manhattan ci sono 6.718 blocchi; un blocco
standard è circa 264 x 900 piedi (80 m × 274 m), ma molti di questi hanno
dimensioni inferiori.
Il numero di chilometri lineare delle strade è 814 km.
Per l’intera New York si ha ancora un valore totale di chilometri paragonabile alla lunghezza delle
coste italiane.
Tornando all’incipit di
questo post, quello che non riesco a spiegarmi è il fatto che malgrado in Italia ci siano
circa 58 milioni di abitazioni, praticamente una per ogni abitante, compresi i
bambini ed inoltre da almeno un decennio sia in corso una forte
deindustrializzazione, il consumo di suolo rimane praticamente costante. Forse, come suggerito da Renzo Piano, imporre il
recupero delle aree dismesse (costruire sul costruito) è ormai diventato una
necessità.